
Nati ad Aosta, i Kina sono stati un gruppo di spicco della scena hardcore italiana ed europea degli anni 80. Abbiamo intervistato Sergio Milani, batterista e voce, con il quale abbiamo ripercorso la storia della band, già ben documentata dalla pellicola “Se ho vinto, se ho perso”. (Dan)

Il luogo di provenienza, metropoli o provincia, è spesso uno dei motivi che porta a iniziare a suonare e alla nascita di una band. Quanta importanza e influenza ha avuto Aosta nella nascita dei Kina? Quali erano gli obiettivi di tre ragazzi che decidono di suonare hardcore ad Aosta?
Era il 1981 e ad Aosta non c’erano molte persone che sapessero che cosa fosse il punk, figurati l’hardcore! Come al solito ad Aosta non c’era un grande fermento né politico né culturale. Per noi era la morte e, semplicemente, non volevamo morire. Gli obbiettivi non è che fossero così definiti, soprattutto all’inizio. Il fatto è che il mondo punk che avevamo iniziato a conoscere era estremamente stimolante, soprattutto perché ci obbligava a guardare oltre la nostra città. Era faticoso, ma siccome c’era molta unione nella scena, gli sforzi davano sempre dei buoni risultati e dal nulla in cui ci sentivamo sprofondare ad Aosta potevamo riemergere ogni volta che andavamo da qualche parte. Se ci pensi, per dei ventenni si trattava già di un risultato non indifferente. Ad Aosta non ci sono mai stati dei centri aggregativi se non il bar dove ci ritrovavamo: un posto lurido frequentato da una marea di alcolizzati e da una manciata di anarchici reduci delle lotte politiche degli anni precedenti. Ma erano più grandi di noi e non abbiamo mai veramente legato neppure con loro. Se volevi uscire da Aosta per trovare qualcosa, dovevi farti 120 chilometri e andare fino a Torino, oppure te ne facevi 200 e andavi a Milano. Non c’erano altri posti: solo Torino a 120 chilometri e Milano a 200. Puoi capire la tristezza! La nostra musica voleva rappresentare sia la nostra voglia di rifiuto di quello che avevamo intorno, sia la ricerca di novità di cose da dire e fare; per cui lo sfogarci fino all’esaurimento nei nostri concerti, quel nostro arrivare esausti alla fine di ogni serata, anche quelle passate in sala prove, era appagante.
Come mi è capitato di dire molte volte, Aosta era come una stazione radio che non trasmetteva nulla. Aosta l’esempio negativo da cui fuggire.
I Kina nascono nel 1982, dopo che avevate suonato al Virus di Milano con una vostra precedente band. Ci raccontate come inizia tutto?
Avevo scoperto che in un bar vicino a casa c’erano dei ragazzi che ascoltavano un po’ di punk. Così, dopo aver convinto Gianpiero a comprarsi un basso, mi sono presentato da quei ragazzi chiedendo se volessero mettere in piedi una band punk. Nessuno aveva mai fatto parte di un gruppo prima di allora e nessuno sapeva suonare. Il nome scelto fu Autofed (Out Of Head, ma scritto in italiano così come si pronuncia). Con gli Autofed abbiamo fatto alcuni concerti, molte cover e qualche pezzo nostro. Oltre al punk rock, ascoltavamo anche gli MDC, i Suicidal Tendencies, i Crass, i Dead Kennedy’s, i Minor Treat , poi è capitato di suonare al Virus di Milano. L’impatto col mondo punk reale non deve essere stato troppo positivo per i nostri amici mentre per Gianpiero e per me era stata una cosa elettrizzante. Per inciso, avevamo suonato proprio da schifo e avevamo fatto la figura dei super provinciali sfigatissimi, però quella sera avevano suonato anche gli Indigesti e io ero rimasto a bocca aperta per tutto il tempo. Dopo quella serata al Virus, il cantante e il chitarrista ci dissero che non intendevano continuare in quel modo e preferivano seguire altre vie più vicine alla new wave di Siouxsie e dei Cure. Dopo un certo periodo di sconcerto (e sconforto) abbiamo trovato Alberto, che il punk non lo conosceva per niente, ma evidentemente era la persona giusta. Era appassionato di cantautori e hard rock, gli abbiamo fatto ascoltare le cose che ci piacevano, scoprendo che per fortuna piacevano anche a lui. Abbiamo recuperato anche un cantante e un altro chitarrista, e in poco tempo eravamo pronti. Siccome non tutte le torte riescono col buco, gli ultimi due arrivati se ne andarono rapidamente come erano venuti… e noi siamo rimasti in tre.
Anche la scelta del nome, Kina, avviene in maniera del tutto particolare, giusto?
Sì, assolutamente casuale: era arrivato il momento del primo concerto e ci siamo resi conto che non avevamo un nome. Dovevamo darlo assolutamente entro una certa data perché fosse messo sui manifesti e così ci siamo impegnati. Abbiamo passato tutta una sera in una gelateria a dire una stupidaggine dietro l’altra ma niente, quel nome non usciva proprio. Alla fine si è optato per Kina, pensando all’inchiostro di china con cui facevamo i disegni per i volantini. Solo che all’epoca ogni “C” la scrivevamo con la K e ogni “A” doveva essere cerchiata per rimarcare la nostra area di riferimento, così da inchiostro di china siamo arrivati a Kina. Ci è piaciuto e lo abbiamo tenuto.
Sentivate una particolare affinità con qualcuna delle scene più grandi di altre città? Oppure qualcosa vi differenziava dagli altri gruppi punk/hardcore dello stesso periodo?
Le scene che si erano sviluppate nelle città erano abbastanza identificabili musicalmente: i gruppi torinesi si riconoscevano dalla velocità, quelli milanesi dal chaos che producevano e così via. Noi venivamo da Aosta, che non era una metropoli e non aveva una tradizione punk. Per alcuni della scena, noi non suonavamo neppure musica veramente punk. Non avevamo mai le magliette dei gruppi del momento (perché non sapevamo mai quali fossero i gruppi del momento), non eravamo mai aggiornati sulle uscite discografiche (perché ad Aosta i dischi non arrivavano e dovevamo andarli a comprare a Torino)… insomma eravamo un po’ emarginati. Però questo ci ha permesso di stare fuori dalle varie correnti e sviluppare un nostro stile personale nel comporre i pezzi, nel cantarli, nel trovare degli arrangiamenti. In parole povere, noi eravamo fuori dal calderone e per questo avevamo una visione e una sensibilità differente. Credo sia stata questa la vera particolarità della musica dei Kina.
Avete iniziato presto a suonare all’estero. Era un’urgenza per voi uscite dall’Italia? Cosa ricordate del primo concerto fuori dal nostro paese?
Credo che fosse un’urgenza per tutte le band. Noi siamo stati fortunati perché abbiamo incontrato delle persone che ci hanno fornito dei buoni contatti. Abbiamo colto l’occasione prendendo degli accordi molto alla buona e siamo partiti appena c’è stata la possibilità. Il primo concerto è stato a Wiesbaden e suonavamo assieme ai Chelsea inglesi. Io li conoscevo bene, avevo i loro dischi ed ero preoccupato di questo accostamento di un gruppo punk rock inglese con uno hardcore italiano.
I Chelsea hanno fatto un bellissimo concerto. Anche i punk sotto al palco erano entusiasti. Poi siamo saliti noi sul palco in mezzo all’indifferenza di tutti. In effetti, anche il nostro abbigliamento non era in linea con lo stereotipo del punk tedesco tutto cuoio, borchie, anfibi e creste. Eravamo coi pantaloncini corti, le scarpe da ginnastica e le camicie a scacchi. I primi minuti di concerto sono stati curiosi perché tutto intorno il mondo si è quasi fermato ad ascoltare, poi le persone si sono fatte sotto al palco, sempre di più, e alla fine c’era un sacco di gente che continuava a chiederci di suonare anche dopo che avevamo finito il nostro set. Un’accoglienza strepitosa.
Parlando di scena hardcore, cosa differenziava gli altri paesi europei dall’Italia?
In Italia avevamo decisamente una grande scena ma pochi posti per suonare. I concerti erano sempre fatti in condizioni precarie con mezzi scarsi e impianti “raccogliticci”. E i mixeristi, il più delle volte, non erano in grado di fare dei suoni decenti perché proprio non riuscivano a capire che razza di musica fosse quella che noi suonavamo. All’estero anche il posto più piccolo o sfigato aveva un impianto completo, con microfoni funzionanti, un certo numero di monitor, dei tecnici che sapevano fare il loro lavoro perché conoscevano il punk e avevano ben presente quale fosse il suono da tirare fuori da ogni band. Altra cosa è che non era raro che nello stesso concerto si trovassero a suonare assieme gruppi hardcore e altri che avessero poco a spartire con questo genere. Una cosa bellissima.
La scelta di cantare in italiano non è mai stato un limite all’estero?
Guarda, nei primi anni 80 i concerti erano la cosa più rumorosa e caotica che si fosse mai vista, e distinguere le parole di qualsiasi canzone italiana era veramente un’impresa anche per noi italiani. L’HC era qualcosa che andava al di là del comprendere i testi, era una condivisione di energia, di rabbia, tutte cose che non avevano bisogno di una traduzione. C’è anche da dire che la maggior parte delle band aveva l’abitudine di fare dei volantini con su scritti i testi delle canzoni e distribuirli prima del concerto. Noi, le prima volte all’estero, avevamo fatto esattamente così, scrivendo i nostri testi in italiano con la traduzione in inglese. Anche nei nostri dischi mettevamo sempre i testi e le traduzioni. I ragazzi apprezzavano molto questa cosa, conoscevano e cantavano le nostre canzoni. Forse abbiamo aperto una porta.
Essere punk/hardcore e suonare all’estero in quegli anni comportava una componente di rischio?
Certamente, ma non tanto per essere punk/hardcore. Il vero rischio era che si partiva sempre all’avventura perché era impossibile poter programmare tutto. Ogni viaggio era un po’ un salto nel buio, non sapevamo cosa avremmo trovato lungo la strada e non sapevamo che razza di posto era quello dove stavamo andando, chi avremmo incontrato. Noi però eravamo talmente entusiasti di quello che facevamo che affrontavamo tutto questo con un’incredibile dose di ottimismo. È capitato che ci esplodesse un pneumatico in autostrada a 130 all’ora o che ci prendesse fuoco il condotto dell’aria calda dell’auto su cui viaggiavamo. È capitato di suonare a capodanno ad Amburgo sotto un tendone mentre fuori nevicava, o di dover interrompere il concerto per andare a sedare risse tra punk e skin. Devo dire che siamo anche stati sempre molto fortunati e abbiamo quasi sempre avuto a che fare con degli interlocutori che si sono dimostrati attenti, competenti, e in generale si sono sempre presi cura di noi.
Ci sono concerti che non dimenticherete mai, nel bene come nel male?
Nel male sì: una volta, ad Aosta, dovevamo suonare in un cinema. Non è venuto nessuno e ci siamo ritrovati noi con l’altro gruppo da soli. Due pezzi loro, due pezzi noi e poi tutti a casa! Un concerto a Taranto fu particolarmente sfigato: suonammo sulla spiaggia con un impianto che era lo stereo di casa di qualcuno, la batteria – o quel poco che c’era della batteria – tenuta insieme dal nastro adesivo, due microfoni funzionanti in tutto e un pubblico composto da quattro persone lontane una decina di metri e una decina di pantegane da 30 centimetri che giravano intorno a noi. C’erano poi una decina di persone che dalla strada si affacciavano di tanto in tanto per guardare chi cazzo era a fare tutto il rumore che si sentiva. Ed infine il rimborso, che non c’era ma lo abbiamo scoperto solo al momento di tornare a casa e solo a forza di insistere siamo riusciti a farci mandare i soldi a rate a distanza di mesi.
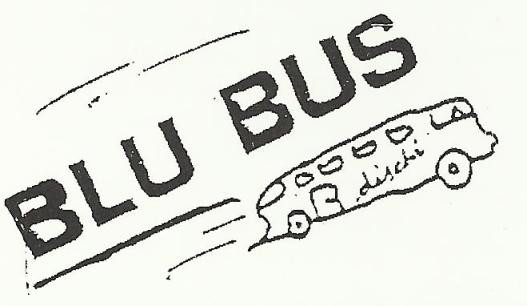
A un certo punto date vita a un’etichetta, la Blu Bus. Era una necessità? Puntare sull’autoproduzione/autogestione fu una scelta sensata?
All’epoca non è che ci fosse l’idea di fare una scelta sensata o meno. L’autoproduzione era una pratica che faceva un tutt’uno con il suonare in un gruppo punk. Era un messaggio politico per comunicare il rifiuto verso un certo modo di concepire la musica e la sua fruizione, per far capire, con l’esempio, che tutto era possibile, anche fare dischi, e che il “nostro” mondo alternativo esisteva veramente e non era un’utopia. Ma l’autoproduzione era anche una necessità perché nessuna vera etichetta discografica avrebbe mai fatto uscire i dischi di musica così “poco gentile e rumorosa”. Così, quando decidevi di fare un disco, te lo autoproducevi. La scena sosteneva le autoproduzioni e i dischi circolavano molto bene. Noi ci siamo spinti oltre, iniziando a collaborare coi Franti col progetto di creare una sorta di marchio di fabbrica per inostri due gruppi e per quelli con cui c’erano forti affinità. Fare uscire un disco comportava un grande lavoro per quelli come noi che non sapevano nulla di come si registra, di come si stampa. Era insomma tutto un mondo da scoprire, però alla fine vedere il risultato era una soddisfazione immensa. Autoprodurre i nostri dischi era quello che volevamo. Credo che abbiamo contribuito fortemente ad aprire una strada e far capire che ciò che sembrava inaccessibile ai gruppi, in realtà era più a portata di mano di quanto si credesse.

“Se ho vinto, se ho perso”, oltre ad essere il titolo di un vostro album, è anche quello di un bellissimo documentario di Gian Luca Rossi. Che effetto fa ripercorrere il percorso della band e capirne oggi la sua importanza?
Guardare il documentario è stata una bella sorpresa anche per me.Gian Luca ha fatto un lavoro egregio ed è riuscito a cogliere e a mettere insieme in modo magistrale tanti elementi sparsi, riuscendo a comporre un puzzle delle nostre vite e della nostra esistenza. Mi sono accorto che di tutto quello che avevamo vissuto, non avevamo mai parlato tra di noi. Forse davamo tutto per scontato e pensavamo non ce ne fosse bisogno. Ascoltare le nostre parole e i nostri pensieri raccontati a Gian Luca come se fossero delle confidenze mi ha emozionato. Devo anche confessare che ogni volta che riguardo quel documentario scopro qualcosa di nuovo, qualche dettaglio, qualche sfumatura che prima era sfuggita. Ogni volta!
Di cosa andate più fieri e avete rimpianti?
Non ho cose particolari di cui andare fiero o che rimpiango, però sono molto contento che le mie canzoni, anche a distanza di tanti anni da quando sono uscite, continuino ad essere cantate e citate da tanti ragazzi. Alcuni di loro sono molto giovani e i Kina non li hanno mai visti, e questo vuole dire che malgrado venissimo dalla periferia del mondo hardcore, avevamo anche noi delle cose da dire che potevano essere ascoltate da tutti.
Quando e perché ha iniziato, secondo voi, a scemare quella scena hardcore italiana di inizio anni 80?
Un punto di svolta si è avuto tra il 1986 e il 1987. Forse si era persa l’energia iniziale. I gruppi faticavano a stare insieme perché si era esaurito quello stimolo innovativo che aveva caratterizzato gli anni precedenti. Le band si scioglievano e molti gruppi nuovi seguivano ormai una sorta di cliché: il punk era diventato un genere con regole e canoni, il metal imperversava e influenzava molte band (anche i Kina, infatti se si ascolta “Cercando”, questa cosa si nota). C’è stato un ricambio generazionale, ci sono state molte nuove persone che si sono avvicinate al punk, ma a parte pochi esempi di ottime band, devo dire che in generale il genere ha fatto un passo indietro in quegli anni.
Tornando ai concerti, avete suonato con artisti come Fugazi e Scream… Cosa ricordate di quei concerti? Avete aneddoti da raccontarci?
Suonare con Fugazi e Scream è stato un onore. Posso dire che si sono dimostrate delle persone meravigliose e assolutamente umili e alla mano, disposte ad aiutare e collaborare. Qualche curiosità? Boh, potrei dirti che Peter, prima dei concerti, passava delle ora a fare esercizi con la voce, oppure che Ian sul palco, dietro gli ampli, aveva un fornellino con una brocca di tè e ogni tanto andava a berne un sorso. Al di la della curiosità, credo che siano cose che confermano quanto queste persone tenessero a essere in forma per poter dare il meglio (e si è sempre visto). Invece, in quanto ad esuberanza, una volta abbiamo dormito nella stessa casa con gli Scream e Dave ha passato la notte a suonare canzoncine country al pianoforte rompendo le balle a tutti… Ecco, quella volta lo avrei ucciso.
A proposito di Dave Grohl, cosa ne pensate del suo percorso dopo Scream e Nirvana?
Beh, Dave ha sempre avuto una forte personalità, oltre ad essere un gran musicista. Per quello che lo conosco, devo dire che lo ammiro molto. Ammetto di non aver seguito molto le sue vicende coi Foo Fighters, infatti ho solo un paio di dischi. Devo però ammettere che, a detta di molti, si è sempre contraddistinto per aver saputo mantenere una certa attitudine. Ha diversi amici ad Aosta e recentemente si è fatto fotografare con una maglietta con scritto Aosta Valley, che loro gli avevano regalato.
Prendendo spunto dal titolo di un vostro brano, cosa rimane di “quegli” anni?
Al di là della consapevolezza di aver vissuto un’esperienza unica, rimane un mondo che in qualche modo sentiamo di aver fortemente contribuito a formarsi e a crescere. Ancora oggi, tutto quello che sono, che penso, che faccio, il modo in cui affronto la vita, lo devo in gran parte all’esperienza di quegli anni. A volte ne ho sofferto, però mi ha formato. Se mi guardo intorno vedo che nel mondo musicale tante cose sono cambiate rispetto ad allora, però anche il mondo esterno è cambiato. A volte in peggio, a volte in meglio. Negli anni 80 eravamo considerati dei pazzi emarginati. Forse era vero, però le nostre idee hanno contribuito a creare una scena dal nulla, una cosa che prima non c’era. Hanno contribuito a dare l’esempio per far sentire la propria voce a chi non l’aveva.

La domanda del Mago Trippone di Trippa Shake
Saresti in grado di suonare un pezzo death metal con il mago Trippone?
Death metal no, dai ti prego! Col Mago trippone però duetterei volentieri qualche pezzo dei Kina e degli Ombra a qualche sagra paesana tra una polenta con spezzatino e un piatto di salsiccia alla brace con patate bollite e insalata di pomodori. Meglio ancora davanti ad una super porzione di trippa e una bottiglia di rosso!
Views: 369
